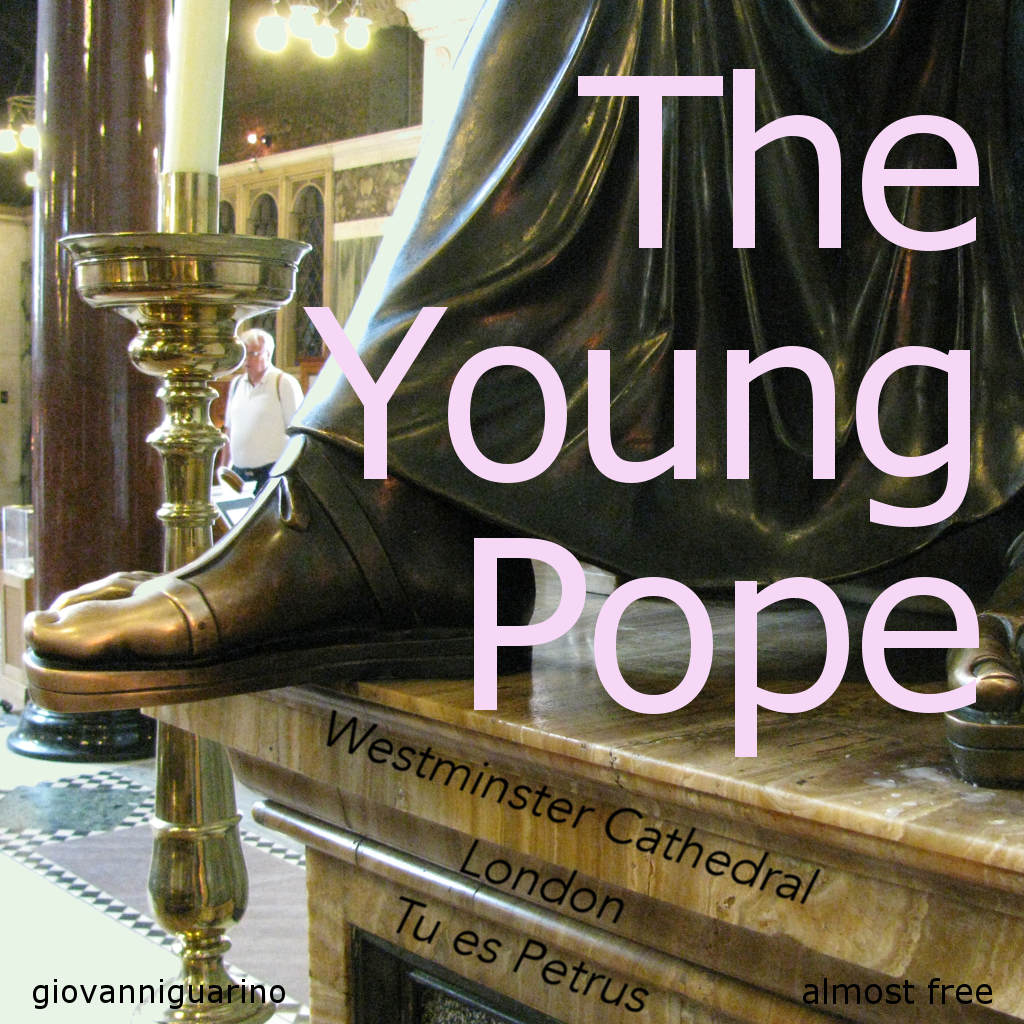
4, 5, 6 marzo 2018
DVD (Schermo televisivo)
Altri film del regista: // Loro // È stata la mano di Dio //
Religioni e/o superstizioni
// The Miracle Club // C’è ancora domani (il matrimonio cattolico) // Kafka a Teheran (Islam) // Rapito (Il Papa Re) // Benedetta (Cattolicesimo) // Holy Spider (Islam) // Profeti (Islam) // Chiara (Cattolicesimo) // Gli orsi non esistono (Islam) // Alla vita (Ebraismo ortodosso) // Il male non esiste (Islam) // Un eroe (Islam) // The Youngest (Ebraismo ortodosso) // Covered up (Ebraismo ortodosso) // Corpus Christi (Cattolicesimo) // Un divano a Tunisi (Islam e psicanalisi) // The dead don’t die (nel commento: fede e dubbio) // Mug Un’altra vita (Cattolicesimo polacco) // Il settimo sigillo (il silenzio di Dio) // L’apparizione (Cattolicesimo) // Cosa dirà la gente (Islam) // Io c’è (religione e denaro) // The Young Pope (Cattolicesimo) //
La storia a puntate del giovane americano stranamente diventato Papa Pio XIII mi era sfuggita quando l’hanno mandata in televisione. Pago il canone Rai, mi basta per quel poco di televisione che vedo, non voglio occuparmi di abbonamenti, di reti, di piattaforme (che palle!), non so neanche bene che cosa siano sky, netflix e compagnia cantante. Non ho voglia di informarmi.
L’informatica, internet sono nate, tra l’altro, per rendere più facile la vita – nel campo della fruizione delle informazioni in qualunque forma. Le stanno rendendo complicate. Perché? Perché vogliono farci tanti, ma tanti soldi.
Mi ha fatto piacere trovare in libreria il cofanetto dei quattro DVD. Ah! Tutto semplice: accendi la scatoletta, ci ficchi dentro il disco, scegli la lingua e parti.
La serie The Young Pope m’incuriosisce da quando ne ho sentito parlare.
Approfittando delle nevicate e del freddo – poca voglia di mettere il naso fuori della porta – mi sono disteso in poltrona e ho fatto partire il lettore per vedere questa serie parecchio tempo dopo la sua prima uscita (2016).
Le strade coperte di neve e il gelo mi hanno fatto completare la visione in tre pomeriggi: quando incomincio una cosa mi piace arrivare fino in fondo.
Mi è molto piaciuto il making of.
Come in molti cofanetti, con l’ultimo DVD si può accedere agli extra, fra i quali c’è il making of, un vero e proprio film-documentario con le interviste al regista e ai suoi collaboratori, al produttore, agli attori principali; si vedono a volo alcune scene con inquadrati i carrelli, la troupe e il regista che dice “azione” e “stop”.
Sono cose, naturalmente, molto costruite, a volte poco interessanti, ma in questo caso viene mostrato come è stata realizzata la scenografia degli ambienti esclusivi che si sono dovuti riprodurre.
Dal momento che i luoghi veri erano irraggiungibili, i progettisti, i tecnici e gli operai hanno lavorato per ricostruire in studio – credo nella mitica Cinecittà – la Cappella Sistina, lo studio del papa, la finestra su piazza San Pietro, ecc.
Bellissimo. Richiamava alla memoria Fellini al lavoro; mancavano solo la sciarpa e il cappello a larghe tese, ma c’erano i basettoni e il sigaro di Sorrentino.
Non seguo le serie televisive: il cinema mi piace al cinema. Non le seguo anche perché preferisco che il regista sia costretto a dire tutto in un’ora e mezza, massimo due ore. Pochi film di durata maggiore accetto, solo alcuni capolavori.
Ben vengano i tagli, l’eliminazione di scene ben girate ma di cui il film può fare a meno, la costrizione alla sintesi.
Immagino l’essere anfibio creato da Guillermo del Toro (The Shape of Water, grande film!) spalmato su una serie di dieci puntate. Che noia sarebbe! Alla fine mi risulterebbero odiose persino le lucertole, che sono rettili, non anfibi, ma hanno anch’esse la pelle squamata.
Nelle serie ogni scena si allunga, molte situazioni si ripetono, si gira molto, non si sacrifica nulla, si monta come se lo spettatore fosse un po’ tonto e avesse bisogno di un ripasso. Ogni tanto bisogna ricordargli che cosa è successo nelle puntate precedenti, spiegargli che quel personaggio, defunto nella terza puntata, è risorto nella ventiduesima senza che nessuno si sia meravigliato. Perché meravigliarsi di un evento così normale e alla portata di tutti?
Battuta (inventata) del personaggio di una serie: «Dato che mi hai abbandonato da bambino, ci siamo ritrovati dopo venti anni, hai rifatto pace con mia madre, lei ha divorziato dal suo secondo marito, siamo in un bar e si è fatto tardi, ce la facciamo una birretta?»
Dopo le prime puntate non sopportavo più il papa giovane mai cresciuto, i vecchi cardinali che scommettono sull’aldilà, ma intanto, mentre sono al di qua, vogliono solo accumulare denaro, promozioni e potere; non sopportavo il mellifluo cardinale Segretario di Stato, incantato davanti alla Venere di Willendorf (Venere per modo di dire), innamorato, forse ricambiato, di suor Mary (si è vista anche la mano grassottella che cerca tremando l’altra mano, più sfilata), in colloquio quotidiano con un ragazzo handicappato, colloquio motivato dal desiderio di farsi perdonare (da chi? Da Dio? Ma ci crede?) le iniquità e nefandezze che il suo lavoro (lui stesso in più occasioni parla di lavoro) lo costringe a fare.
È un lavoraccio, si sa; qualcuno lo deve pur fare.
Nessuna partecipazione alle vicende che si svolgono sullo schermo, tranne alcuni episodi rimasti impressi nella memoria; quando il giovane papa, in una delle ultime puntate, è scoppiato in un pianto dirotto, ho pensato: finalmente ha smesso quell’aria strafottente stampata sul volto inutilmente bello (qui agisce l’invidia, bisogna compatire).
Alcune scene sono molto belle.
Sui titoli di testa: la camminata del papa lungo il corridoio – mentre, sui quadri esposti, dalla stella cometa si forma il meteorite che alla fine colpisce la statua di papa Wojtyla – completa, si potrebbe dire, con una punta di ironia, la scultura La nona ora di Maurizio Cattelan.
La stella cometa, che annunciò la nascita di Cristo, ora annuncia la fine della chiesa. È rimasta solo una enorme potenza temporale. San Paolo, caduto da cavallo, ci è risalito sopra ed è andato in giro per il mondo per fare affari e accumulare potere.
La sequenza che più mi ha colpito e mi ha fatto pensare che Sorrentino è un genio del cinema, anche se The Youth non mi è piaciuto, si apre all’improvviso, inaspettata: i papi che hanno preceduto Lenny sul soglio pontificio girano per le stanze che erano, che sono ancora, la loro casa; papa Giovanni, con la sua bell’aria di curato di campagna, apre la porta, entra, la chiude alle sue spalle e poi, tutti insieme, riuniti intorno a un tavolo, guardano fisso Lenny; uno di loro, forse Giulio II (ritratto da Raffaello Sanzio), dopo avere alzato la mano come un bambino a scuola (fa tenerezza), rispondendo a una domanda di Lenny, dice («caro collega …») che il papa deve credere più in sé stesso che in Dio; poi ci pensa un po’ su e ammette che si tratta di una banalità, aggiungendo che spesso i luoghi comuni sono veri e il potere è una banalità.
La scena è bella; però il termine “collega” è fuori luogo, banale come la frase di Giulio II. E che cazzo! Veramente Giulio II crede di essere stato una specie di capufficio?
Diane Keaton, in pigiama con la scritta I am a virgin sul petto, richiama alla memoria la ragazza minuta e spiritosa, un po’ goffa, affascinante, dei primi film di Woody Allen.
Per anni ho creduto che fosse la figlia di Buster Keaton e notavo una somiglianza del volto e del modo di muoversi con il mitico supposto padre (un grande del cinema comico americano, insieme a Charlie Chaplin, ai fratelli Marx, a Stan & Ollie). Poi ho scoperto che in realtà si chiama Diane Hall (Io e Annie, titolo originale: Annie Hall); Keaton è il cognome della madre, casalinga, non imparentata con il regista e attore del cinema muto. Nelle prime puntate della serie sembra, e un po’ è, la solita mamma che vuole manipolare il figlio, intenzionata a lavorare dietro le quinte e a diventare la vera papessa. Il personaggio evolve, comprende la necessità di farsi da parte per consentire al giovane papa ferito nel profondo di crescere e di separarsi da lei, e non usa l’arma solita: il ricatto affettivo. Si allontana tranquillamente per fare il lavoro che le piace, allevare bambini, prendendo il posto di una megera che il giovane papa santo, giustamente, ha fatto soffocare in accordo con Dio (ce ne fossero di santi che fanno morire soffocata la gente come quella!).
Paolo Sorrentino deve avere un forte senso religioso (è certo, dato che ha una forte fede calcistica, come dice qualcuno nel film, non mi ricordo chi, forse Voiello) o, comunque, probabilmente crede che un’istituzione antica e potente come la Chiesa abbia dietro di sé qualcosa di soprannaturale. Dietro di sé, non sempre nel presente.
Pio XIII dialoga realmente con Dio, è realmente un santo, capriccioso e non buono, anzi spietato o indifferente alla sorte dei suoi sottoposti, alle loro sofferenze, come, forse, se esiste, è indifferente Dio.
Questo lungo, troppo lungo, film è anche, tra tante cose, la storia di un orfano che non ha mai superato il trauma dell’abbandono e oscilla tra aggressività e tenerezza (fa pena quando si prende cura del bambino che ha contribuito a far nascere, gli cambia i pannolini, rendendosi insopportabile ai genitori).
All’inizio il film ricorda The birds (1963), di Alfred Hitchcock.
Uccellacci neri sono presenti in entrambi i film, svolazzanti in The birds, arrabbiati in The Young Pope, appollaiati dietro una statua, dietro una colonna, a spiare qualcuno, pronti a colpire.
Si nascondono come i bambini che giocano a nascondino, e noi dobbiamo credere che nessuno li veda, nessuno indovini la presenza degli uccellacci appostati a spiare.
Addolciscono il paesaggio le suorine bianche impegnate al lavatoio e la suora campionessa di calcio, autrice di un tiro smarcante molto bello da vedere.
Nel film di Hitchcock c’è un personaggio, una ragazza ricca e snob, che può fare quello che vuole senza dare conto a nessuno, proprio come il giovane papa capriccioso; rifiuta una ricca colazione per aspettare una Coca-Cola cherry zero (facciamo pure la pubblicità, ma non tiriamo sempre l’acqua al mulino delle multinazionali del diabete!).
Sorrentino parte troppo velocemente, rispetto a Hitchcock, senza una preparazione; gli uccellacci parlano tra loro come fossero i componenti di una banda di camorristi, si raccontano le cose più segrete, le manovre di potere, in modo non allusivo ma esplicito, senza nessuna cautela: «Voi africani siete ingenui, credete veramente che lo spirito santo scelga il papa», «Il nome dello spirito santo è Voiello», «Voiello è il demonio incarnato», ecc. Chissà se il famoso pastificio, nato a Torre Annunziata (oggi Barilla) ha cacciato qualcosa per questo nome (a pensar male si fa peccato, però s’indovina, diceva il Divo).
La sospensione, nel film di Hitchcock, è avviata da un comportamento anomalo degli uccelli, che diventano sempre più aggressivi in un posto bellissimo e accogliente, dove vive gente tranquilla, cordiale e simpatica.
La tensione viene costruita lentamente, gradualmente, con l’accumularsi dei segni di qualcosa di inspiegabile e pauroso.
Ci aspettiamo l’assalto, però il modo in cui si verifica ci prende di sorpresa.
Nel film di Sorrentino, in un clima teso che fa pensare al peggio, monta la suspense (troppo velocemente), poi appare Voiello e non vediamo un uccellaccio ma un tenero uccellino, un po’ sfigato, accompagnato da un fedele servitore e spia che ha la stessa faccia e la stessa voce di Johnny Dorelli (è il figlio) e la stessa aria distaccata, ironica. Ci tranquillizziamo: nessun assalto finale, il thriller è finito prima di cominciare.
Il Segretario di Stato della Santa Sede si confessa senza interrompere i suoi calcoli sulla calcolatrice tascabile (segue la grande finanza come una massaia fa i conti al mercato); non aspetta la conclusione del rito e l’assoluzione (non ha tempo e pare non potersene fregare di meno), lasciando il confessore nel dubbio su come possa essere considerata in confessionale l’attrazione per la statuetta di una donna vissuta venticinquemila anni fa (sempre la famosa Venere, se così vogliamo chiamarla, di Willendorf) .
Sorrentino non si preoccupa di tenere lo spettatore sospeso attraverso il racconto, anzi non se ne importa, come Voiello dell’assoluzione. Gli piace caricare lo schermo di simboli, di segni e di sogni che richiederebbero l’astrologo per essere interpretati (battuta rubata a Gigi Proietti, che si riferiva ai suoi inizi nel teatro sperimentale). Il passaggio dalla realtà al sogno e viceversa avviene senza interruzione di continuità, lascia lo spettatore perplesso, dubbioso: che cosa sto vedendo?
Come nei sogni, dall’incubo si passa come niente al comico, alla risata liberatoria. Il papa giovane – completamente immerso, quasi affogato negli antichi paramenti, con in testa un copricapo che lo costringe a sporgersi in modo innaturale e a fare strane smorfie, assiso sulla sedia gestatoria, dopo aver fatto un discorso che solo un dittatore asiatico in possesso di bomba nucleare può fare (totale chiusura al mondo e alla realtà) – convince i cardinali (se davvero accadesse, non esiterebbero a chiamare gli infermieri di un ospedale psichiatrico) a baciargli il piedino impantofolato, vezzosamente sporto, invogliando il Segretario di Stato, un po’ restio, con un gesto deciso della mano, a compiere l’atto di sottomissione.
La battuta più divertente è rivolta dal cardinale Voiello a Tonino Péttola (questo è l’accento giusto, perché è una parola dialettale napoletana, sdrucciola): «Tonino Péttola, il motivo di questa visita è che tu … e ruttə o cazzə» (non è necessario tradurre).
«Non sono un matematico», diceva Totò, «ma questo paziente ha l’intestino troppo lungo» (da Totò diabolicus, regia di Steno); non sono un regista o un esperto di cinema, ma, secondo me, questa serie in dieci puntate, se fosse ridotta a un film della durata di due ore, sarebbe un capolavoro.
Così, invece, è come l’intestino del paziente di Totò: troppo lunga. Devo ammettere che a me tutte le serie sembrano troppo lunghe. Tutte! Non che ne abbia viste molte. Ho visto I Sopranos, che mi è piaciuta, ma pure mi è sembrata troppo lunga.
Secondo me è un errore raccontare in dieci, venti puntate una storia che si può raccontare in due ore.
POST SCRIPTUM
Siccome sono fissato con il problema di come si rendono le lingue straniere nei film, sono andato a rivedere il primo episodio nella versione originale, che, in un film internazionale, è la versione in lingua inglese.
Ho scoperto che Silvio Orlando non è doppiato, ma parla in inglese, giustamente con accento italiano, anzi napoletano, ma va benissimo, l’accento è perfettamente corrispondente al personaggio. “Ho scoperto” è una forma retorica, perché se ne era parlato a suo tempo. Bene.
Il papa, nei colloqui interpersonali, parla in inglese. È normale, trattandosi di un papa americano, ed è il motivo per cui Silvio Orlando ha imparato a pronunciare le sue battute in inglese, perché ha molti colloqui con il papa.
Arriviamo al discorso del papa alla folla radunata in piazza San Pietro.
Non so se la versione del DVD sia quella arrivata al pubblico di mezzo mondo; se è così, il papa parla alla folla come un attore shakespeariano recita Hamlet e (miracolo!) la folla capisce.
Fa un po’ effetto vedere questa folla, soprattutto di romani, e rendersi conto che capiscono perfettamente la lingua di Shakespeare, nonostante il papa non si sia impegnato minimamente per farsi capire, come se San Pietro si fosse trasferito (il santo e la Basilica, con tutta la piazza) a Londra o a New York.
Non si poteva chiedere a Jude Law che, peraltro, in un’occasione parla in spagnolo con un cardinale sudamericano, di imparare il discorso, solo il discorso che rivolge alla folla in piazza San Pietro, e quello finale in piazza San Marco, nella lingua parlata del posto?
Sarebbe venuto fuori un accento simpatico che avrebbe reso più realistica e coinvolgente la situazione, anche per un pubblico internazionale, aiutato a capire con i sottotitoli.
